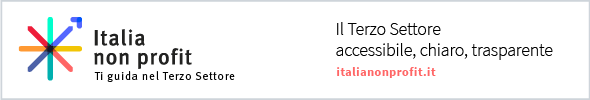Patria, arte e bolle di sapone
Il ritratto che Giuseppe Molteni fece nel 1831 a Gian Giacomo Poldi Pezzoli ci restituisce l’immagine di un bambino di nove anni bello, vestito di sete preziose e spensierato, intento a fare bolle di sapone. Il piccolo nasceva del resto benissimo: la madre, Rosina Trivulzio, apparteneva a una delle famiglie più antiche dell’aristocrazia ambrosiana, figlia per di più di quel marchese Gian Giacomo che possedeva la più spettacolare collezione d’arte e la più ricca biblioteca privata (con il Codice di Leonardo detto appunto «Trivulziano») di Milano. Quanto al padre, Giuseppe Poldi, se era di nobiltà ben più fresca e modesta (ereditò secondo cognome e titolo da uno zio, insieme a una fortuna colossale), era però fra gli uomini più ricchi della città. E poiché la sorella maggiore del piccolo Gian Giacomo sarebbe morta appena ventenne, lui fu ben presto l’unico erede di quella montagna di averi. Un’educazione di prim’ordine, la passione per l’arte e la cultura, alimentata dai viaggi d’istruzione con la madre, presto vedova, e dalla frequentazione con i letterati che lei amava riunire nelle magnifiche residenze di Milano (in corsia del Giardino, oggi via Manzoni, dove è il museo) e di Bellagio, fecero il resto e formarono un giovane uomo che nel 1846, raggiunta la maggiore età, poteva disporre di tutto: denaro, nobiltà, cultura, lingue straniere e familiarità con opere d’arte inarrivabili (dalla «Coppa diatreta» del IV secolo d.C. ai dodici «Arazzi dei mesi», su cartoni del Bramantino) viste fin da bambino nel palazzo del nonno materno. A tutto si aggiungeva una fervente fede patriottica, nutrita dall’ambiente in cui il giovane Giacomo Poldi (così amava firmarsi) crebbe: Cristina Trivulzio Belgiojoso, protagonista del Risorgimento, era cugina della madre, che spesso la visitò, con il figlio, a Parigi dove lei viveva in esilio. Cristina era assai più radicale ma anche le amicizie che Giacomo si scelse a Milano sarebbero state quelle del liberalismo, seppure moderato, come è provato dalla biblioteca, in cui i testi di Vincenzo Gioberti si alternavano a quelli di Carlo Botta e di Cesare Balbo. A mitigare un’immagine di perfezione virtuosa perfino un po’ stucchevole c’era però il privato: con grande scandalo di mammà, Giacomo prediligeva infatti le attricette o, peggio ancora, le mogli altrui. E infatti non si sposò mai. Si innamorò e convisse con una protetta di Cristina Belgiojoso, Eleuteria, sposata con un mansueto farmacista, riuscendo a mandare su tutte le furie persino la Belgiojoso, che certo non era una bigotta. Non solo, ma quasi certamente ebbe una figlia, Camilla, da Giuseppina Parravicini, sposata con il chimico Francesco Cavezzali, che come Giacomo era un mecenate di Francesco Hayez e di altri pittori del tempo. L’ambiente era quello: patrioti e intellettuali engagé, secondo il modello che si era imposto tra Sette e Ottocento e che chiedeva a chi più aveva un forte impegno in politica e nel sociale (lui promosse tra l’altro una scuola per artigiani). Così, quando Giacomo entrò in possesso della sua fortuna, prese a finanziare tanto generosamente (e tanto visibilmente) i patrioti da essere costretto nel 1848 all’esilio a Lugano, subendo anche la confisca dal patrimonio. Approfittò del passaporto svizzero per viaggiare per l’Europa, visitando musei e collezioni d’arte e di armi (la sua prima passione, questa) e quando rientrò a Milano, mentre gli austriaci soffocavano brutalmente ogni voce filoitaliana, si diede alla creazione di quello che fu il grande capolavoro di una vita: la casa-museo che, coerentemente con il suo credo, volle lasciare alla città e al pubblico godimento, dopo avervi riunito tesori ineguagliabili, dai dipinti, specie leonardeschi e del Rinascimento toscano ma non solo, alle armi e armature, riunite in un’armeria medievale (lo stile dei patrioti, che evocava l’età dei liberi Comuni), dallo Studiolo dedicato a Dante, gloria patria ed eroe dell’Italia unita, alle altre stanze di cui fece, secondo il gusto del tempo, forgiato dalle grandi esposizioni internazionali, un’antologia delle più raffinate arti decorative antiche e contemporanee. «Gian Giacomo Poldi Pezzoli. L’uomo e il collezionista del Risorgimento» (catalogo Allemandi), la bella mostra curata da Lavinia Galli e Fernando Mazzocca, aperta fino al 13 febbraio nella sua casa-museo, il Museo Poldi Pezzoli appunto, frutto com’è di ricerche d’archivio che hanno portato alla luce una messe di documenti (tra i quali il quaderno «Mia cassa particolare», in cui dal 1861 documenta minuziosamente gli acquisti di opere d’arte), ricostruisce a meraviglia la sua figura e la cornice in cui realizzò il suo sogno, e nei 150 dell’Unità ne riporta vividamente alla luce il volto di generoso patriota.
© Riproduzione riservata
da Il Giornale dell'Arte numero 315, dicembre 2011